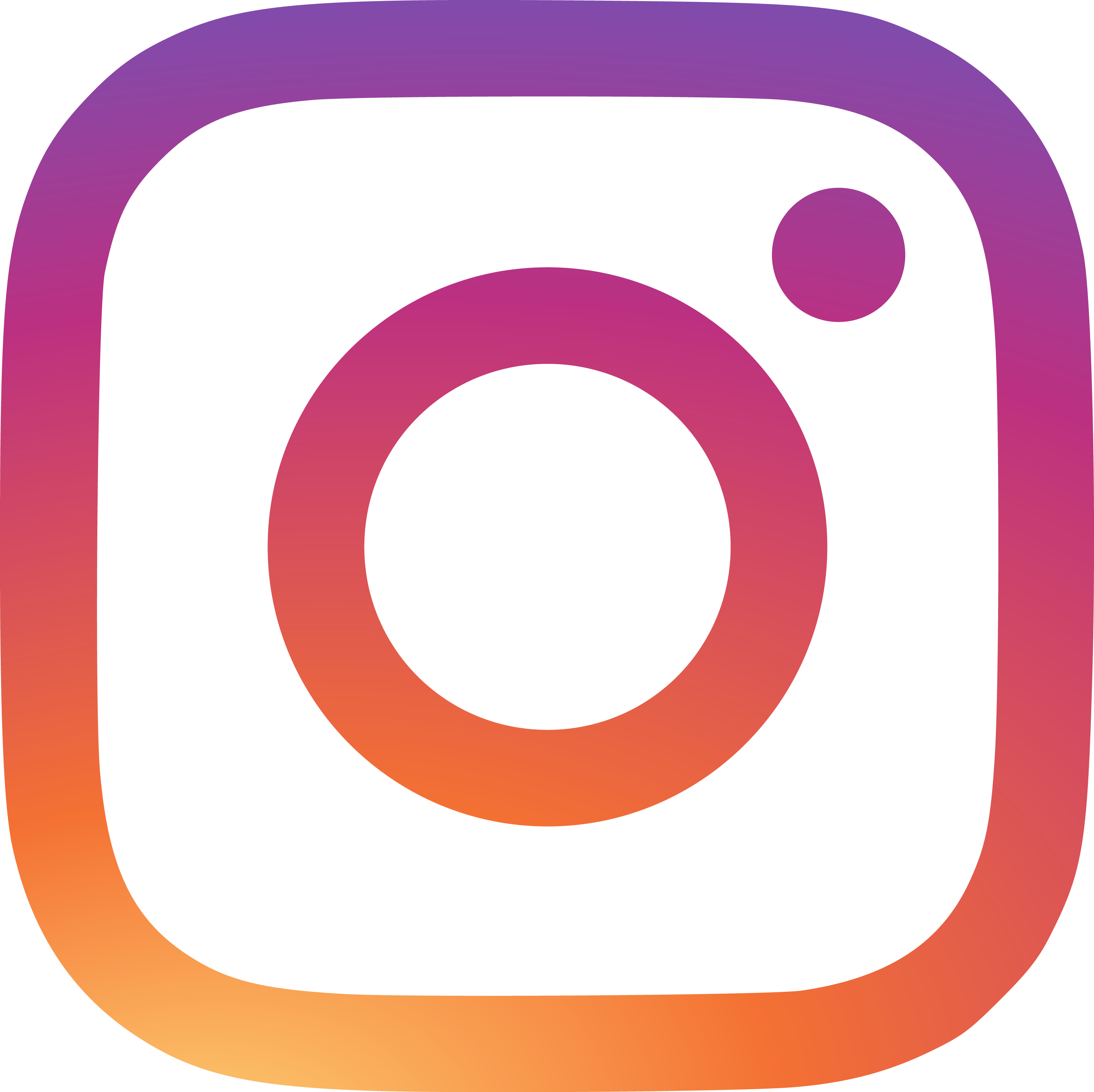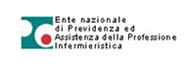LUIGI IANNACONE RACCONTA LA GIORNATA DI CHI VIVE DA PROTAGONISTA LA LOTTA AL COVID-19

CORONAVIRUS LUIGI IANNACCONE COTUGNO NAPOLI / Un bambino smilzo, sulle spalle uno zaino che si fa sempre più pesante fino a diventare un macigno: è il peso che si porta dietro Luigi, infermiere presso l'U.O.C di Anestesia, Rianimazione Terapia Intensiva dell'Ospedale Cotugno di Napoli. Il suo è il peso che si porta sulle spalle ogni persona che in questo momento combatte la difficile battaglia contro il coronavirus in prima linea, nella trincea che sono diventati gli ospedali italiani. Lì dove il dolore fa parte della quotidianità, vissuto isolati dal mondo, dietro una mascherina che segna il viso o peggio ancora in una terapia intensiva, sperando - addormentati - che gli occhi potranno riaprirsi e tornare ad abbracciare i propri cari.
Luigi Iannacone, in esclusiva a Calciomercato.it, racconta il suo quotidiano contributo alla lotta al Covid-19: "Lavoro da sei anni come infermiere, da due al Cotugno: non avrei mai pensato di trovarmi ad affrontare una pandemia. C'è chi sceglie di essere infermiere e chi si ritrova a farlo: a farlo sono bravi tutti, esserlo però è un'altra cosa". Esserlo è una quotidianità fatta di notti fuori casa, doppi turni, festivi lontano da casa e "la vita privata come tessere di un puzzle da incastrare tra un turno e l'altro". Una quotidianità resa ancora più difficile dall'esplosione del coronavirus: "La mia è cambiata come tutti, mi sento defraudato della libertà che forse, erroneamente, abbiamo dato per scontato per troppo tempo. Anche a lavoro è cambiata: a fine turno si è stanchi fisicamente. I dispositivi di protezione fanno male sul volto e le tute di biocontenimento fanno sudare tanto. Ma si è stanchi soprattutto psicologicamente. Ogni volta che mi vesto lo faccio con la consapevolezza che per diverse ore non potrò bere, andare al bagno o semplicemente grattarmi il naso. Per ore respiro all'interno di una mascherina, così stretta che in alcuni momenti giurerei di non riuscire a respirare. Il caldo delle tute non aiuta. Il sudore inizia a colare dalla fronte bruciandomi gli occhi e lasciandomi un retrogusto amaro sulle labbra".
Una sensazione non facile che la mattina, quando suona la sveglia ti fa venir voglia di spegnerUn macigno reso ancora più pesante da questo nemico invisibile che isola le persone: "Nei reparti di degenza il paziente è solo e non sarà possibile per lui avere contatti diretti la famiglia. Il tutto è reso ancor più stressante perché la persona si trova circondato da figure avvolte da spesse tute in plastica con visi nascosti da occhiali e mascherine. Qui subentra poi la nostra capacità nel saper dosare le giuste parole per tranquillizzare chi abbiamo di fronte e fargli capire cosa sta succedendo. Da noi in terapia intensiva le emozioni sono ancora più amplificate. Siamo consapevoli che il nostro sarà l’ultimo sguardo che il paziente vedrà prima che la sedazione inizi a fare effetto ed i nostri occhi saranno poi i primi che rivedrà quando si risveglierà dopo tanti giorni". Ma forse va ancora peggio ai familiari, costretti ad attendere notizie date per telefono: "La loro è la situazione più drammatica: ricevono solo telefonicamente aggiornamenti sulla salute dei loro cari. È una sensazione simile a quando un nostro famigliare si sottopone ad un intervento chirurgico: le porte della sala operatoria si chiudono e si resta per ore senza sapere cosa sta succedendo. Ecco, se amplifichiamo centinaia di volte quello stato animo fatto di paura, ansia e impotenza, forse potremmo iniziare a capire cosa prova un familiare che resta a casa. È inevitabile per loro porsi domande pensando al proprio caro, interrogativi come 'Chissà se ci rivedremo'. Perché è inutile nasconderlo, purtroppo in tanti muoiono. E non c'è neanche la possibilità dell'ultimo saluto. Ciò che ti lacera profondamente è che il Coronavirus ti lascia morire da solo" la e continuare a dormire: "Una parte di me vorrebbe tanto farlo, restare a casa al sicuro, senza alcun rischio contagio. Un'altra parte mi sprona invece ad alzarmi, a dare il mio contributo. Sarei bugiardo a dire di non avere paura: ce l'ho ogni giorno che esco di casa. Paura di positivizzarmi, di finire in quarantena, di non poter tornare a casa e rivedere la mia famiglia. Ma nonostante mi senta vulnerabile, ogni giorno sono lì, nella mia rianimazione, a fare del mio meglio per i miei pazienti".
Fare il massimo, nonostante il peso del dolore altrui: "Immaginatevi un bambino delle elementari dal fisico smilzo che avanza verso scuola con in spalla un grosso zaino pesante. È così che spesso ci sentiamo. Si pensa che con gli anni il tuo cuore diventi di ghiaccio e che i problemi e il dolore altrui non ti tocchino più in alcun modo. Non c'è cosa più falsa. Certo, l'esperienza ti insegna a scindere la tua vita privata da quella lavorativa, ma non sempre è possibile. Chi sceglie di essere infermiere è consapevole che il dolore e la sofferenza altrui faranno parte della propria quotidianità. Ma il dolore deve essere solo una parola, non una sentenza".
"In psicologia si definisce 'Il dolore dei curanti', una lenta e silenziosa sofferenza che nasce dal continuo e incessante contatto col dolore dei malati, un dolore dai mille aspetti. È il dolore della realtà della morte, della menomazione, della paura del male fisico, della solitudine ospedaliera, dell'impotenza, della perdita dell'autonomia, della separazione degli affetti e dalla propria vita che forse non sarà più come quella di prima. Quando un paziente condivide con te il suo dolore è come se tu in qualche modo riuscissi in parte a strappaglielo, alleggerendolo. Ma tu sei da solo, i pazienti sono tanti.
A fine giornata hai sul groppone un bel po' di dolore altrui, come se lo zaino di quel bambino diventasse a fine giornata un grande macigno".
CORONAVIRUS, LUIGI IANNACONE: "NON SIAMO EROI, CHE SOLLIEVO L'AFFETTO DELLA GENTE"
Soli però i malati non sono, perché l'Italia ha scoperto anche eccellenze che prima sembrava nascoste, come appunto il Cotugno: "C'è sicuramente orgoglio, ma anche un pizzico di rabbia: siamo da sempre un centro di riferimento regionale per la cura di malattie infettive come meningiti o per il trattamento dei pazienti sieropositivi. L’attenzione avrebbe dovuto riceverla già da tempo. Per anni la gente ha guardato al nostro nosocomio con distacco e paura, trattandoci come appestati".
Ora, invece, medici e infermieri assurgono al ruolo di eroi: "Non lo siamo: è il nostro lavoro, la nostra parte. Continuiamo a fare ciò che abbiamo da sempre fatto, solo in condizioni di protezione diverse. L'affetto della popolazione è un toccasana per le nostre giornate. Lo si percepisce eccome. Una mattina recandoci a lavoro abbiamo trovato uno striscione in stoffa affisso alle grate dell'Ospedale con un colorato 'Grazie' da parte di un dodicenne. Anche molti ristoranti, pasticcerie e note catene alimentari ci hanno fatto omaggio delle loro prelibatezze. Per molti potrà sembrare un gesto banale, ma in un momento così particolare anche bere un semplice caffè e gustare un cioccolatino per 'staccare'la spina quei pochi minuti durante un turno di lavoro non è cosa da poco".
Così come non è cosa da poco continuare a restare a casa per evitare che tutti i sacrifici fin qui fatti vadano sprecati: "Alla gente che non rispetta le restrizioni viene voglia di raccontargli un turno di lavoro, descrivergli cosa significa per un paziente positivizzarsi al virus, ospedalizzarsi, allontanarsi dai propri cari o peggio venire intubato. Vorresti tanto fargli capire che il 'Restate a casa' non è solo uno slogan in voga, ma è l'unica soluzione attualmente utile per limitare i contagi. È importante che la gente capisca che non esiste ancora una cura definitiva per questo virus, e che anche il miglior medico è impotente nei confronti di questo microorganismo. Per questo ribadisco: "Restate a casa. Aiutateci ad aiutarvi"". E anche a rendere meno pesante quello zaino reso un macigno dal peso del dolore.